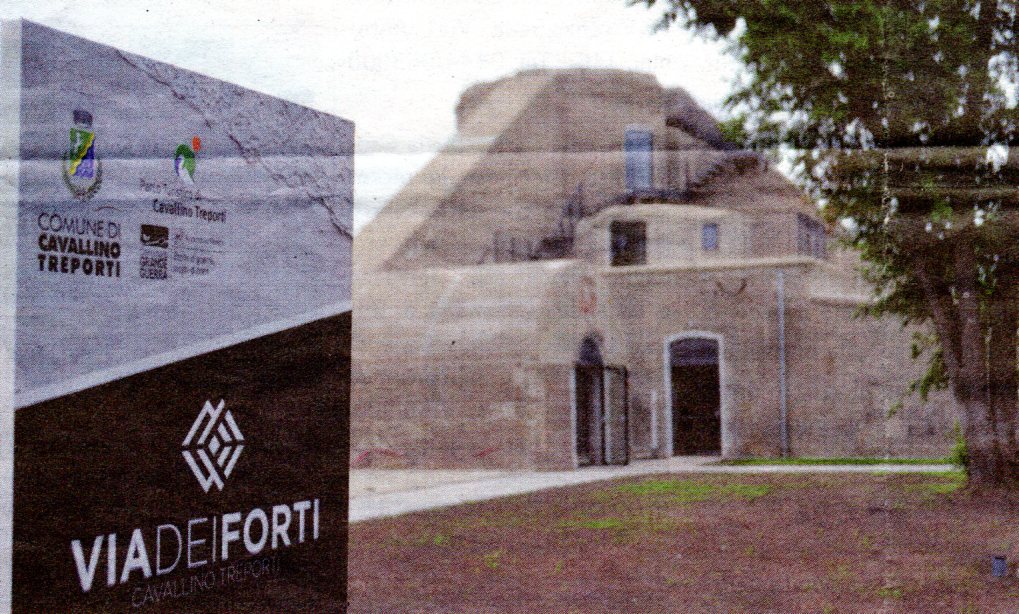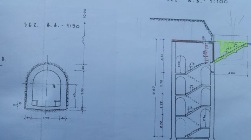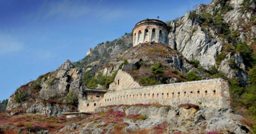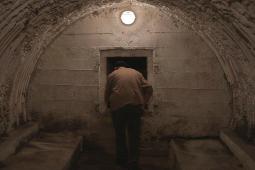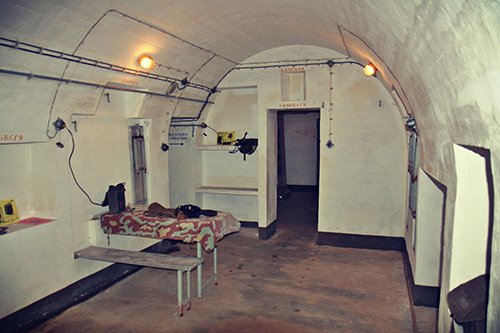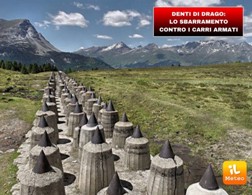|

Lo stabilimento di La Spezia ed il connesso sito di Aulla, quest’ultimo
posto all’interno del comprensorio del Centro Interforze Munizionamento
Avanzato (CIMA) della Marina Militare, rappresentano il centro integrato
d’eccellenza missilistica di MBDA Italia.
Accanto ai programmi legati
allo sviluppo, produzione e mantenimento in servizio dei sistemi
missilistici antinave, che fin dalla nascita del sito rappresentano il
cuore dell’eccellenza del centro ed oggi registrano l’evoluzione delle
famiglie Marte e Teseo, il centro di La Spezia/Aulla di MBDA Italia si
appresta ad ampliare il proprio contributo al know-how strategico
nazionale.

Nel settore dei sistemi
superficie-aria, il centro si sta preparando per l’assemblaggio finale
del CAMM ER che si aggiunge alle attività legate alla famiglia Aster,
anch’esse in evoluzione e s’affaccia sul settore aria-superficie con
l’estensione della vita operativa e l’ammodernamento della munizione
stand-off a lunga portata Storm Shadow. Un’attività che si sviluppa di
pari passo con la ricerca e sviluppo (R&D) interna, la cooperazione con
le Forze Armate ed il CIMA, ed i numerosi programmi Ricerca e Sviluppo
(R&D) con le università, industria e centri dedicati della Difesa, in
un’ottica di sviluppo e mantenimento a livello strategico della
sovranità e produzione a favore della Difesa e dell’export nel settore
missilistico.
Nato negli anni ’70 per
supportare la decisione politica di dotare il paese di una capacità
sovrana nel settore del segmento missilistico tattico di superficie, le
cui attività si svilupparono inizialmente attraverso una cooperazione
industriale tra Oto Melara e Matra Engins per sviluppare il sistema
missilistico antinave Otomat (denominato Teseo dalla Marina Militare
italiana), lo stabilimento di La Spezia ed il connesso sito di Aulla
all’interno del comprensorio del Centro Interforze Munizionamento
Avanzato (CIMA) della Marina Militare sono oggi protagonisti di un nuovo
sviluppo produttivo e tecnologico. Costruito in quegli anni per
soddisfare le necessità del programma Otomat/Teseo, che ha riscosso un
notevole successo nel tempo con 1050 unità prodotte dai due paesi e
definiti gli accordi con il Ministero della Difesa per realizzare ad
Aulla (CIMA) le attività piriche inerenti l’integrazione, il collaudo
finale e lo stoccaggio delle munizioni presso installazioni oggi gestite
da MBDA Italia,
il binomio La Spezia/Aulla si è sviluppato nel tempo in
un centro d’eccellenza che vede la realizzazione completa di un sistema
missilistico, dalla fase di progettazione, sviluppo prototipi e test, a
quella di produzione con integrazione inerte e pirica, collaudo,
stoccaggio, consegna al cliente, mantenimento ed eventuale estensione
della vita operativa/ammodernamento del sistema.

Ogni anno MBDA investe nel
comprensorio di La Spezia-Aulla circa sette milioni di euro, alimenta la
‘supply-chain’ locale per circa 20 milioni di euro, realizza tecnologia
allo stato dell’arte anche grazie ad una stretta collaborazione con le
università, mantenendo risorse qualificate e sviluppando mutue
collaborazioni con le Forze Armate, come nel caso del sito del Centro
Integrazione Missili (CIM) all’interno del comprensorio del CIMA della
Marina Militare. Sviluppatosi su di un sedime che oggi conta 22.500 mq,
di cui 10.500 coperti su 3 edifici, con una nuova palazzina uffici
(edificio 9), una struttura laboratori, produzione e magazzini (edificio
7) in ristrutturazione, ed un’area assemblaggio lanciatori e revisione
motori turbojet, il sito di La Spezia è passato nel 1997 in AOSM (Alenia
Oto Sistemi Missilistici) a seguito della costituzione di Alenia Difesa,
e quindi in Alenia Marconi Systems (AMS) e più recentemente nel 2001, è
confluito nella neonata MBDA. Presso quest’ultimo sito, le attività
principali riguardano lo sviluppo test e produzione (integrazione
inerte) di missili ed installazioni di lancio per piattaforme aeree,
navali e terrestri, a cui s’aggiungono progettazione meccanica ed
aerodinamica, simulazione e ‘ambiente sintetico’, ‘Hardware in the Loop’
(HWITL) e prove d’interferenza e compatibilità elettromagnetica (EMI/EMC),
revisione motori turbojet e laboratorio per tecnologie duali. A questi
s’aggiunge l’attività d’integrazione pirica, collaudo finale e
stoccaggio delle munizioni nonché la produzione della sezione anteriore
della famiglia di missili Aster presso il CIM ‘Sergio Ricci’ (dal nome
dello storico collaboratore di Gustavo Stefanini, ‘padre’ di Oto Melara,
al quale ha succeduto nella guida dell’azienda) ospitato presso gli
edifici 41 e 47 del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA)
della Marina Militare. Con quasi 200 dipendenti a tempo indeterminato ed
un’età media di 44 anni, di cui il 26% under 30 ed il 10% over 60 (con
una suddivisione fra uomini e donne pari rispettivamente all’80/20%), il
sito integrato di La Spezia/Aulla presenta principalmente cinque
macro-aree rappresentate dal centro sviluppo software sistemi
missilistici (CIS-CSSSM), settore operazioni, integrazione e validazione
del sistema d’arma, laboratorio equipaggiamenti di test ed il
laboratorio di ricerca e sviluppo industriale avanzato. Come anticipato,
il sito copre l’intero ciclo che porta alla creazione di un nuovo
sistema d’arma missilistico ed il supporto lungo la vita operativa, che
necessita di un “ambiente operativo fisico-logico” o area ad elevata
riservatezza (classifica uguale e superiore a ‘riservato’ e sottoposta a
vincoli di controllo del dipartimento delle informazioni per la
sicurezza – DIS) rappresentato dal CIS-CSSSM, dove vengono redatti ed
archiviati i documenti relativi ai programmi, mantenuto l’ambiente di
gestione dei requisiti funzionali e modellazione di sistema, quello di
modellazione e simulazione algoritmi

nonché l’ambiente di sviluppo
software e test funzionale per il sistema operativo del missile, sistema
di lancio e simulatori. L’area principale del sito è rappresentata da
quella destinata all’assemblaggio e manutenzione delle sezioni ed
assemblaggio finale (inerte a La Spezia ed integrazione pirica ad
Aulla) delle munizioni, assemblaggio e test degli equipaggiamenti
pirotecnici, sviluppo e validazione degli strumenti e della linea
d’assemblaggio, nonché banchi di sviluppo e test, design meccanico ed
elettrico. In pratica le varie componenti del missile arrivano dagli
altri siti del gruppo compreso il Fusaro, fornitori terzi ma anche dallo
stesso sito di La Spezia e qui vengono assemblati insieme nelle diverse
sezioni e queste a creare la munizione, che viene poi sottoposta a test
di verifica integrativa del sistema e della sua componentistica
nell’apposita area dedicata.
Lo stabilimento di La
Spezia Presso il sito di La Spezia si trovano attualmente la linea
d’assemblaggio dei missili Marte di seconda generazione ed in
particolare risultano in produzione le munizioni del secondo lotto per
l’impiego da nave (Mk2/N) destinate agli Emirati Arabi Uniti. Un’altra
linea d’assemblaggio è dedicata al Marte ER, di cui nel corso della
visita al sito, era in fase di realizzazione l’unità di pre-serie con il
nuovo turbojet Williams WJ-24-8G. Quest’ultima dovrebbe essere impiegata
per il primo tiro di qualifica quest’autunno presso il Poligono
Interforze di Salto di Quirra (PISQ) in Sardegna. Un ulteriore linea
d’assemblaggio riguarda il sistema missilistico antinave pesante Teseo,
di cui parleremo oltre, che ha visto dalla metà anni ‘2000
l’assemblaggio con ammodernamento alla più recente versione Teseo Mk2/A
delle munizioni della precedente versione Mk2 per la Marina Militare
nonché la produzione per l’estero sia nella versione precedente Mk2 che
della nuova Mk2/A.

Su richiesta e specifiche
della Marina Militare, MBDA Italia sta lavorando alla fase di
definizione finale della configurazione di una nuova versione denominata
Teseo Evo (o Evolution) con capacità antinave e contro bersagli
terrestri, di cui parleremo oltre, il cui completamento del design e
assegnazione del contratto di sviluppo dovrebbe arrivare entro la fine
del 2018.
Nel recente passato, presso il sito di La Spezia è stata
effettuato anche la preparazione e qualificazione dei lanciatori delle
batterie SAMP/T per l’Esercito Italiano a dimostrazione del completo
spettro d’esperienze accumulato a vantaggio di future attività.
In
particolare, come meglio vedremo oltre, il sito integrato di La Spezia/Aulla
si sta preparando per le attività legate al programma CAMM ER ed in
particolare alla realizzazione della linea di assemblaggio inerte e
pirica per il nuovo sistema missilistico con relativi sistemi di test e
supporto, nonché sistema di lancio e trasporto.
Una volta assemblate, le
munizioni e relativi sistemi di lancio passano all’area di integrazione
e validazione, dove vengono sottoposti a test e collaudo compresa quella
del seeker grazie ad una camera anecoica di nuova adozione dove viene
simulato l’inseguimento del bersaglio, disturbi e corrispondenza
alle prestazioni richieste.

Qui viene anche realizzata
l’integrazione con il sistema di lancio e condotta l’accettazione del
cliente nonché la gestione dei relativi tiri dopo aver completato
l’integrazione pirica ad Aulla, se non equipaggiati di testata
telemetrica.
Presso il laboratorio ‘test equipment’ sono portate a
termine tutte le fasi di progettazione, realizzazione, integrazione,
installazione e manutenzione relativa alle attrezzature di test, anche
in partnership con le piccole e medie imprese locali, e con l’obiettivo
di realizzare prodotti nuovi e modulari per l’impiego multi-attività, a
cui s’aggiunge la realizzazione di workshop per i clienti ed il supporto
al training.
Un’altra importante area del sito di La Spezia è
rappresentata dal WSSE (Weapon Systems Simulation & Experimentation)
dedicato all’integrazione dei sistemi e simulazione in ambiente
sintetico anche con altre realtà aziendali e della Difesa per nuovi
sistemi missilistici come nel caso del Multilayer Coastal Defence System
(MCDS) con primo cliente il Qatar e sistemi integrati per la difesa
aerea e contro i missili balistici (IAMD) con le nuove versioni della
famiglia Aster, come nel caso del sistema SAAM ESD con missili Aster 30
Block 1 sempre per il Qatar. A questi s’aggiunge Il Compact Warfare
System Package ‘Sea Ranger’ ovverosia il pacchetto modulare di comando e
controllo e sistemi d’arma per la difesa di imbarcazioni veloci di
ridotte dimensioni con Brimstone e Marte MK2/N per attività antinave e
SIMBAD-RC per la difesa aerea.

Tale suite di simulazione del
sistema integrato di plancia e gestione dei sistemi d’arma in ambiente
operativo consente, grazie alla piattaforma sviluppata da IBR Sistemi
con MBDA, di sviluppare un alto livello di realismo e presentazione ai
potenziali clienti sia in occasione di saloni o visite presso il sito. È
inoltre presente un’area dedicata alla revisione dei motori turbojet del
sistema missilistico Teseo per la Difesa e per l’export. Il sito di MBDA
Italia dispone infine di una zona laboratorio R&D denominato LaMBDA (Laboratory
for Advanced Industrial Research and Technology – MBDA) che ricerca
l’eccellenza tecnologica per applicazioni industriali anche duali, con
particolare attenzione alle opportunità offerte dai ‘lateral market’. Il
laboratorio collabora attivamente con PMI, università, startup e Forze
Armate in ottica ‘Open Innovation’, costituendo un ‘hub’ di tecnologie
sul territorio.
Il laboratorio ha una forte connotazione multidisciplinare ed è integrato nel panorama europeo del gruppo,
offrendo contributi nei principali settori, dal monitoraggio delle
condizioni di funzionamento ed ambientali attraverso sistemi HUMS (Health
and Usage Monitoring System) di nuova generazione per l’integrazione nei
sistemi di lancio e negli stessi sistemi missilistici, alla stampa 3D
con materiali termoplastici ad alte prestazioni, allo studio e
caratterizzazione di materiali e impatto ambientale come nel caso dei
materiali reattivi ad alta energia per le teste in guerra, sistemi
fotonici, armi laser, sistemi elettronici ad alte prestazioni ed armi ad
impulso elettromagnetico, come nel caso del programma THOR che renderà
inefficaci, bruciandone i circuiti elettronici, i sistema d’arma
avversari. Come anticipato, il CIM di Aulla nell’ambito del comprensorio
del CIMA, costituisce un elemento integrante e distintivo del sito
spezzino di MBDA Italia e del suo rapporto con la Difesa. In aggiunta
all’integrazione pirica sui sistemi missilistici presenti e futuri,
nell’ambito del programma Aster il CIM svolge una missione unica
effettuando la produzione della cosiddetta ‘sezione anteriore’ per tutti
i missili Aster, con un rateo di circa 20 unità al mese.

Quest’ultima che include la
testata in guerra viene assemblata ad Aulla ed una volta collaudata
viene inviata in Francia presso il sito MBDA di Selles-Saint-Denis, dove
si trova la linea d’assemblaggio Aster per tutti gli operatori della
famiglia del sistema missilistico.
In aggiunta alla testa in guerra, la
sezione anteriore del missile Aster comprende anche seeker, blocco
sensori, pacco batterie e spoletta.
I recenti ordinativi di missili
Aster nel Medio Oriente unitamente agli sviluppi del programma Marte ed
in un prossimo futuro del CAMM ER, hanno portato ad un piano di
potenziamento delle capacità del sito senza ampliare le infrastrutture.
Al fine di assicurare un incremento del rateo di assemblaggio pirico e
quindi di produzione e fornitura dei sistemi missilistici ordinati,
verrà portata a termine una trasformazione degli spazi a disposizione.
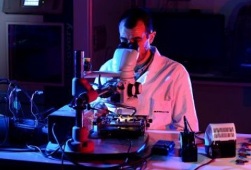
In aggiunta alla line di
produzione della sezione anteriore dei missili della famiglia Aster,
ciascuna delle due aree del CIM dispone di diverse aree d’integrazione
pirica comprendente una sala di test e due celle dove avviene
l’integrazione vera e propria con un pre-assemblaggio dei relativi
componenti, un accoppiamento con la testa e l’assemblaggio finale.
Secondo il piano di potenziamento ideato dagli ingegneri e tecnici di MBDA Italia, anche la sala di test viene trasformata in area
d’integrazione dove potrà essere svolto l’intero ciclo d’assemblaggio
missilistico finale.
In questo modo viene assicurato il rispetto dei
livelli di gestione del materiale pirico nelle diverse aree che
s’aggiunge all’ottemperanza al TULPS (Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza) che classifica i componenti pirici in 5 categorie a
secondo delle loro caratteristiche e del tipo di reazione (detonanti e
deflagranti) ed impone che vengano stoccati in depositi differenti (un
deposito per ogni categoria).

Accanto a tale potenziamento,
il CIM vedrà in un prossimo futuro l’entrata in operazioni della linea
d’assemblaggio pirica del sistema missilistico superficie-aria CAMM ER
destinato al sistema EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions), a
cui s’aggiunge l’estensione della vita operativa e l’ammodernamento del
sistema stand-off Storm Shadow in servizio con l’Aeronautica Militare
italiana. In particolare, grazie ad un contratto che dovrebbe essere
assegnato entro la fine dell’anno, il CIM si sta preparando
all’inertizzazione delle munizioni Storm Shadow per il successivo
ripristino a seguito del previsto programma di MLU lanciato nel 2017,
che al momento attuale coinvolge soltanto la Francia e la Gran Bretagna.
In questo contesto, le munizioni prodotte per l’AMI verranno rese inerti
presso il CIM e poi spedite in Gran Bretagna per essere sottoposte
all’ammodernamento al pari delle munizioni per gli altri due
paesi. Successivamente torneranno al CIM, al termine del ciclo, per
l’integrazione pirica finale prima della riconsegna.
Marte ER: l’antinave
intermedio leggero Sviluppato dall’allora Oto Melara – la cui area
missilistica è successivamente confluita, attraverso diversi passaggi
come sopra evidenziato, in quella che oggi è MBDA -, quale missile
antinave leggero destinato ad essere impiegato da nave (Sea Killer Mk1),
elicottero (Marte Mk2) e successivamente velivoli ad ala fissa da
addestramento ed attacco al suolo (Mk2/A),
il sistema d’arma Marte
nell’attuale (seconda generazione) versione ha registrato la sua prima
applicazione per l’impiego da velivoli ad ala rotante ed in particolare
inizialmente a bordo dell’EH-101 della Marina Militare dal 2006 e
successivamente dalla piattaforma NHIndustries NFH-90, che ha completato
l’integrazione e qualificadel sistema nel 2012.

Il programma ha
successivamente registrato lo sviluppo a partire dal 2009 della versione
navale (o lanciata da nave) che è stata qualificata nel 2012, la cui
munizione (canister di trasporto e lancio + missile) e sistema di lancio
costituiscono il fulcro della variante per l’impiego operativo antinave
da nave. La seconda generazione del missile Marte (Mk2) si caratterizza
per una riduzione della lunghezza della cellula grazie all’impiego di
due booster laterali, una sezione anteriore di maggiore diametro per
ospitare il seeker RF denominato SM-1S fornito da Leonardo
(precedentemente Selex SI/Galileo) che rappresenta lo stesso utilizzato
per il sistema missilistico Otomat/Teseo Mk2/A, ed elettronica digitale
con nuovo computer di missione.
Con una lunghezza di 3,85 metri, un
diametro massimo di 316 mm ed un peso di 310 kg (con booster) che
scendendo a meno di 300 kg per la versione senza i medesimi (Mk2/A per
velivoli ad ala fissa sia da addestramento/combattimento che da
pattugliamento), il Marte Mk2 ha una portata di oltre 30 km, un sistema
di guida integrato altimetro/inerziale per la guida ‘mid-course’ e
terminale radar attiva con avanzate capacità di risposta alle
contromisure (ECCM). Grazie alla possibilità di lanciare fuori-asse fino
a +/-90 gradi, con un ridotto tempo di risposta (3 secondi necessari
all’accensione ed altrettanti per il lancio), la capacità di programmare
tre ‘way-point’ sul piano orizzontale, l’altezza per il punto di impatto
e la zona di ricerca del seeker attraverso il sistema di pianificazione
della missione, il Marte Mk2 si caratterizza per avanzate capacità
d’ingaggio di bersagli di superficie con una testa in guerra della
classe 70 kg ad attivazione ad impatto o di prossimità, elevate capacità
di manovra terminale per incrementare la sopravvivenza contro sistemi
per la difesa ravvicinata delle unità sotto attacco. In aggiunta
all’impiego da elicottero in servizio con la Marina Militare, il Marte è
stato testato da piattaforma ad ala fissa per il pattugliamento
marittimo Airbus C-295 e da velivolo da addestramento/attacco al suolo
Leonardo M-346. Per la prima piattaforma (C-295), è stata eseguita una
serie di campagne di volo per l’acquisizione dei dati ambientali,
culminata con una prova di sgancio eseguita con successo nel 2013. Per
la seconda piattaforma invece è stata studiata l’interazione funzionale
della capacità antinave effettuata con il Marte Mk2/A.
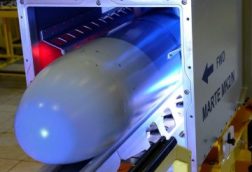
Nella versione lanciata da
nave, denominata Marte Mk2/N, la munizione e il relativo sistema di
lancio sono stati acquisiti dalla Marina degli Emirati Arabi Uniti per
l’impiego da bordo delle unità veloci classe ‘Ghannatha’, per cui il
paese mediorientale ha acquisito un ulteriore secondo lotto di
munizioni, attualmente in fase di produzione. Quest’ultima versione,
seppure nulla è stato mai confermato ufficialmente dall’azienda, è stata
acquisita anche dal Turkmenistan per equipaggiare le unità veloci
d’attacco da 55 metri costruite in Turchia dai cantieri Daersan e dotate
di due lanciatori singoli. Lo sviluppo della terza generazione della
famiglia Marte, seconda quanto risulta ad AD, risale al 2006
quando la Marina indiana ha emesso un requisito operativo per un sistema
missilistico antinave con portata intermedia da installare su
piattaforma ad ala rotante. Per soddisfare tale esigenza e l’interesse
di diverse altre Marine militari mondiali che necessitavano di un
analogo sistema, MBDA Italia ha sviluppato il Marte ER (Extended Range).
Concepito fin dall’inizio dello sviluppo come sistema d’arma
multi-piattaforma capace di essere impiegato non soltanto da elicotteri,
batteria costiera e piattaforma navale, ma anche da velivolo da
combattimento o fast-jet come l’Eurofighter Typhoon in aggiunta a
velivoli da addestramento/attacco al suolo o combattimento, partendo da
una comune cellula che si differenzia per i piani di controllo del
missile al fine di soddisfare i stringenti requisiti in termini di spazi
e gestione della munizione sotto l’ala dei fast-jet ed il sistema
d’interfaccia con la medesima piattaforma lanciatrice.
Gli ingegneri e
tecnici di MBDA Italia sono pertanto intervenuti con lo sviluppo di una
nuova cellula dal diametro costante in grado di accogliere una nuova
sezione propulsiva per assicurare una portata superiore ai 100
chilometri ma con dimensioni tali da poter continuare l’installazione su
elicotteri di medie dimensioni e velivoli d’addestramento/attacco al
suolo come la piattaforma Leonardo M-346.

Al posto del motore a razzo
del Marte Mk2, la versione ER (Extended Range) adotta un turbojet
Williams WJ-24-8G. Rispetto alla versione Mk2, la versione ER ha i
controlli in coda: tale soluzione assicura una risposta più immediata ai
comandi di attuazione ed una maggiore manovrabilità complessiva.
La
variante ER è un missile di lunghezza pari a 3,6 metri e dal peso
di 330 kg (inclusi i boosters). L’incremento di portata ha portato alla
modifica del sistema di guida: alla suite basata sul solo dato inerziale
è stato aggiunto l’uso del dato GPS, grazie all’inserimento di un
ricevitore GPS per la fase di crociera. Per quest’ultima fase, possono
essere impostati fino a dieci ‘way point’ tridimensionali. L’impiego del
ricevitore GPS incrementa ulteriormente la precisione della navigazione
e consente l’attacco di bersagli quali navi in porto o installazioni in
prossimità della costa sulle base delle coordinate geografiche.
Per
quanto riguarda il seeker, non è stato ancora selezionato, facendo
presente che il sistema in banda ‘X’ installato sul Marte Mk2 e prodotto
da Leonardo è lo stesso di quello installato sull’Otomat Block IV/Teseo
Mk2A. Sfruttando l’estesa esperienza sviluppata nell’ambito dei seeker
per i principali programmi europei rappresentati dai sistemi d’arma
Aster e Meteor, di cui MBDA Italia detiene la design authority, quest’ultima
ha sviluppato un ricevitore digitale a banda larga in fase di
validazione in ambiente operativo, che unitamente ad un seeker in banda
Ku con antenna tradizionale, potrebbe trovare applicazione sul Marte ER
con tempi di messa a punto compatibili con le attuali richieste di
consegna al primo customer del sistema missilistico, rappresentato dal
Ministero della Difesa del Qatar.

A ciò s’aggiunge una testata
in guerra dal peso complessivo di 70+ kg con spoletta d’attivazione ad
impatto o di prossimità che consente di colpire ed affondare unità quali
vedette veloci e corvette e di provocare significativi danni anche a
fregate, rimanendo al di fuori del raggio d’azione delle loro difese
missilistiche aeree. La terza generazione del sistema missilistico è
inoltre dotata di un sistema di pianificazione delle missioni più
evoluto, che consentirà un’ulteriore ottimizzazione della traiettoria in
quadrimensionale ai fini dell’ingaggio. Come anticipato il Marte ER è
stato concepito quale sistema multipiattaforma e conseguentemente
sviluppato in due versioni ed una variante.
La versione Naval Ground
(N/G) destinata ad essere lanciata da nave o batteria costiera e quella
lanciabile da elicottero o H/C (Helicopter) si differenziano perché la
prima viene lanciata da un canister mentre nel caso della versione HC,
quest’ultima dispone dell’interfaccia meccanica e connettori,
rappresentati da morsetti di sospensione e sistemi di bloccaggio, per
l’aggancio al lanciatore per elicottero. La variante Fast Jet (FJ) si
differenzia rispetto alla versione H/C per la mancanza di booster, in
quanto il missile sfrutta la velocità della piattaforma, un diverso
sistema di armamento e sicurezza o SAU (Safety and Arming Unit), un
inviluppo di volo differente e modifiche alla cellula nella parte di
interfaccia con il pilone aereo. Successivamente al rilascio dalla
piattaforma FJ lanciatrice, la munizione plana fino al punto di
accensione motore. A queste differenze si aggiunge la predisposizione
della munizione ad un’interfaccia Mil-Std 1760, la più recente per
l’impiego aeronautico che consente uno scambio d’informazioni fra
piattaforma e sistemi d’arma secondo i più moderni standard.

In servizio presso le forze
armate nazionali e di diversi altri paesi, la società AEREA ha
sviluppato i seguenti prodotti che s’interfacciano con la famiglia di
missile Marte, compresa la versione Extended Range (ER) per l’impiego da
velivoli ad ala rotante e fissa. Si tratta dell’HLRU (Hook Lifting
Release Unit), unità di rilascio gravitazionale da 14 pollici impiegato
sulle principali piattaforme elicotteristiche (EH101 e NH-90 con
particolare riferimento all’impiego con il Marte, ma anche AW159, AW/T129
e molti altri) ed i sistemi AHDERU ed ALDERU (Advanced Heavy/Light Duty
Ejector Release Unit).
Questi ultimi rappresentano eiettori da 30
pollici e 14 pollici rispettivamente, che equipaggiano la linea Eurofighter Typhoon attualmente nella configurazione con energizzazione
pirotecnica, ma già disponibili anche in versione pneumatica di cui le
specifiche versioni da 14”PLDERU-B e PLDERU-P5N (Pneumatic Advanced
Light Duty Ejector Release Unit) sono state selezionate per
l’equipaggiamento della linea Leonardo M346 Master. Le versioni NG ed HC
dispongono già di un cliente di lancio rappresentato dal Ministero della
Difesa del Qatar che nel settembre 2016 ha assegnato a MBDA un contratto
del valore di circa 640 milioni di Euro per lo sviluppo e la fornitura
della versione NG per l’impiego da batteria costiera o MCDS.
Il primo
lancio di qualifica del sistema Marte ER è previsto per questo autunno
presso il PISQ e la produzione di serie del sistema per il cliente
qatariano dovrebbe iniziare nel 2020 per consentire le prime consegne
del sistema MCDS l’anno successivo.

L’architettura del sistema
MCDS comprende un numero non divulgato di batterie equipaggiate con
missile Marte ER ed Exocet MM40 Block 3 che s’interfacciano con un
centro di comando fisso ed un pacchetto di mezzi per la logistica e
manutenzione.
Ciascuna batteria o CDS (Coastal Defence System)
comprenderebbe secondo quanto ha appurato AD, tre mezzi ruotati con
lanciatore quadrinato derivato da quello per il sistema missilistico
Exocet, una stazione di comando e controllo ed una per i sensori,
entrambe su mezzo ruotato. Le batterie Exocet si differenziano
esclusivamente per il numero di mezzi lanciatori (2 anziché 3), mentre
il tutto comprende un sistema di sorveglianza e designazione bersagli
basato su sistema non pilotato, peculiarità del sistema prescelto dal
Ministero della Difesa del Qatar.
Quest’ultimo lo scorso marzo, ha
assegnato nel corso del salone di DIMDEX 2018, un contratto a MBDA per
la fornitura del sistema Marte ER nella versione HC per l’impiego dai
futuri elicotteri navali NHIndustries NFH90, anch’essi ordinati nel
corso del medesimo evento insieme alla medesima piattaforma in versione
da trasporto tattico, con contratto destinato a diventare operativo
entro la fine dell’anno, e consegna delle relative piattaforme prevista
a partire dalla metà del 2022. Come anticipato da Analisi Difesa, MBDA e
Leonardo su contratto assegnato a quest’ultima quale capocommessa dal
consorzio Eurofighter, hanno lanciato nell’ottobre 2016 una System
Definition Phase (SDP) di un più ampio programma per l’integrazione del
sistema Marte ER sul velivolo da combattimento Typhoon, facendo del
sistema missilistico di MBDA l’arma antinave standard per il velivolo
paneuropeo.

Nel corso della SDP che si è
completata lo scorso aprile, sono stati effettuate con successo prove di
integrazione e sgancio a terra di mock-up del missile dal velivolo
strumentato IPA 2 di Leonardo Velivoli a Caselle. L’Aeronautica Militare
si è fatta garante dell’integrazione di tale capacità per il primo
cliente internazionale, rappresentato dall’Aeronautica del Kuwait. Il
sistema Marte ER fa parte del pacchetto che MBDA ha proposto al Kuwait
per soddisfare le specifiche richieste del paese mediorientale ed il cui
contratto dovrebbe essere assegnato a breve.
Sulla base di tali
specifiche e richieste di altri potenziali futuri utilizzatori del Marte ER, MBDA ha sviluppato due diversi profili di missione.
Il primo
riguarda un attacco diretto ad un target, generalmente pre- ianificato,
dove il lancio avviene entro poche centinaia di metri di quota a
velocità subsonica mentre il secondo viene effettuato nel corso di
pattugliamenti aerei a media-alta quota contro bersagli che vengono
evidenziati dai sensori imbarcati o su designazione esterna.
MBDA è in
attesa di ricevere il contratto per la fase successiva d’integrazione
del sistema missilistico sul Typhoon che, occorre sottolineare, è stato
concepito per ridurre al minimo il carico del pilota e le informazioni
necessarie all’impiego del sistema, trattandosi di un’arma
‘fire-and-forget’

Fra i potenziali clienti del
Marte ER in versione lanciabile da Fast Jet, potrebbe essere annoverata
l’Aeronautica Militare italiana che con la perdita della capacità
antinave causa il ritiro dal servizio dei missili Kormoran, avrebbe
espresso interesse per tale soluzione come testimoniato dal suo
coinvolgimento nelle attività d’integrazione sulla piattaforma Typhoon a
vantaggio del Kuwait. Lo stesso documento programmatico pluriennale
della Difesa Italiana per il periodo 2017-2019, parlando di programmi
non ancora finanziati, evidenzia la necessita dell’approvvigionamento
del sistema missilistico Marte ER per miglioramento capacità d’ingaggio
aria/superficie, senza peraltro specificare la piattaforma. Anche
l’Aeronautica del Qatar potrebbe diventare un potenziale cliente della
versione fast-jet, in caso di richiesta del sistema, grazie all’attuale
presenza del medesimo nel futuro inventario delle Forze Armate del paese
mediorientale. In parallelo allo sviluppo del Marte ER, MBDA sta
lavorando ad una serie di capacità potenziate del sistema missilistico
raggruppate intorno a tre principali aree: l’adozione di un data link
che consentirebbe il re-targeting in volo, oltre alla capacità
d’identificazione certa e distruzione del bersaglio, un nuovo seeker
multi-mode in radiofrequenza ed infrarosso/laser semi-attivo ed una
nuova testata di potenza e capacità maggiorate.
L’evoluzione del Teseo
Con l’avvicinarsi della fine della vita operativa del sistema Teseo Mk
2A (designazione export Otomat Mk 2 Block IV) che assicura il lungo
braccio delle capacità antinave delle unità della Marina Militare
Italiana, sfruttando le sinergie con l’evoluzione del sistema Marte ER,
MBDA Italia e la forza armata stanno lavorando ad un piano per lo
sviluppo di una nuova generazione del sistema d’arma, meglio conosciuta
come Teseo Mk2/E (dove E sta per Evolved o più semplicemente Evo).

Quest’ultima è destinata ad
incorporare miglioramenti prestazionali e capacitivi rappresentati da
portata potenziata, letalità maggiorata e aumentata efficacia in fase
terminale. Con fondi già disponibili, il contratto per lo sviluppo del
nuovo sistema Teseo Mk2/E è atteso entro il 2018, al fine di ridurre al
minimo eventuali gap capacitivi determinati dalla conclusione della vita
operativa dell’attuale munizione prevista per l’inizio del prossimo
decennio. Sviluppato a partire dal 1969 quale private venture fra le
allora società Oto Melara e Engins Matra (più tardi confluita in Matra
BAE Dynamics ed oggi MBDA France) successivamente fuse nel gruppo MBDA,
ed entrato in servizio con la Marina Militare italiana nel gennaio 1976,
il sistema missilistico Otomat denominato Teseo dalla Marina Militare
Italiana è inizialmente evoluto in una versione Mk2 dotata di gittata
potenziata sviluppata a partire dal maggio 1973, con primo lancio nel
gennaio 1974 e sviluppo completato nel 1976. Sebbene negli anni ’80, le
due società avessero studiato una versione supersonica dell’Otomat, con
propulsione ramjet e denominata Otomach, capace di raggiungere una
velocità massima di 1,8 Mach, tale progetto è stato abbandonato per una
soluzione che comprendesse capacità stealth e di aggiornamento e
verifica degli effetti della missione, ma anche quest’ultima è stata
lasciata senza seguito e nell’ottobre 1992, il Ministero della Difesa
francese ha definitivamente abbandonato il programma Otomat per dedicare
i propri sforzi al potenziamento del sistema missilistico Exocet.
L’Italia invece ha proceduto nello sviluppo dello studio di una versione
stealth del missile con cellula caratterizzata da avanzate soluzioni
tecniche, testate in camera anecoica. Denominato Otomat/Teseo Mk3, un
modello di questa soluzione è stato presentato all’edizione 1994 di
Euronaval, attirando l’attenzione dell’US Navy. Quest’ultima già
conosceva l’Otomat in quanto aveva acquistato un piccolo lotto di
munizioni quale sistema antinave da valutare contro le difese delle
proprie navi con risultati estremamente positivi per il sistema ed
allarmanti per l’US Navy. Tale attività ed i successi sviluppi del
sistema sopra riportati, hanno portato alla firma di un memorandum of
nderstanding fra Italia e USA nel novembre 1995 per un’analisi congiunta
di opzioni per un missile anti-superficie di nuova generazione (NGASM,
New Generation Anti-Surface Missile).

Prima che la US Navy perdesse
interesse nel progetto, definitivamente abbandonato nel 1999 per
perseguire capacità di ‘deep-strike’, il Ministero della Difesa italiano
ha assegnato ad AMS un contratto per lo sviluppo e la valutazione di un
sistema di guida multi-sensore RF/infrarosso, che unitamente alla
cellula stealth avrebbero dovuto portare all’avveniristico sistema
d’arma che ha ricevuto il nome Ulisse, prima di essere definitivamente
abbandonato esclusivamente per motivi economici.
Verso la fine degli
anni ’90, Alenia Marconi Systems (AMS) ha cominciato a lavorare a
versioni migliorate dell’Otomat Mk2 e dopo aver sviluppato e venduto
alla Malesia la versione Block III della munizione, nel corso di
Euronaval 2000 è stato annunciato il lancio delle attività sulla
versione Block IV. Lo sviluppo vero e proprio di quest’ultimo modello
per la Marina Militare, è partito nel 2001 ed il primo test di lancio
con testata telemetrica del Teseo Mk2/A (Otomat Mk2 Block IV per
l’esportazione) si è svolto con successo sul Poligono Sperimentale e di
Addestramento Interforze di Salto Di Quirra (PISQ) il 30 maggio 2006.
Successivamente nel novembre 2007, un lancio con missile completo è
stato realizzato con successo sempre sull’area a mare dello stesso
poligono dal caccia lanciamissili Durand de la Penne. Con il
completamento delle attività, NAVARM ha assegnato a MBDA un contratto
del valore di 45 milioni di euro per l’ammodernamento di 38 missili e 4
sistemi di lancio per i caccia classe ‘Durand de la Penne’ e ‘Doria’. Il
Teseo Mk2/A si presenta come un’arma antinave ‘fire-and-forget’ con
capacità ognitempo ed una gittata superiore ai 180 km con profilo di
volo quasi esclusivamente a bassa quota e sea-skimming.

Con una lunghezza di meno di
cinque metri ed un peso al lancio di 780 kg, il Teseo Mk2/A si
caratterizza per un sistema propulsivo incentrato sul turbogetto
Turbomeca TR 281 Arbizon III per la fase di crociera ed attacco finale,
in grado di assicurare un’elevata veloce subsonica e significative
capacità di manovra. Dotato di un sistema di navigazione ‘mid-course’
incentrato su INS/GPS e capacità di essere riprogrammato in volo grazie
ad un sistema data link installato sulla piattaforma lanciante, il Teseo
Mk2/A presenta un sistema di guida terminale basato su seeker RF attivo
in banda ‘X’ fornito da Leonardo e dotato di avanzate capacità in
termini di contromisure elettroniche, in grado di assicurare manovra
evasive terminali e capace di variare l’altezza dell’impatto. A questi
s’aggiunge una testata in guerra da ben 210 kg, in grado di essere
attivata ad impatto o in prossimità. Grazie al sistema GPS, l’ultima
versione del Teseo è in grado di attaccare bersagli navali in ambito
litoraneo, portuale e terrestre sulla base delle coordinate geografiche
di questi ultimi. Il missile dispone di un avanzato sistema di missione
con way-point tridimensionali (si presume qualche decina), profilo di
missione sea skimming e capacità d’ingaggio multiplo simultaneo con
direttrici predefinite d’attacco, zone di non sorvolo (no fly zone) e di
allerta collisione verticale con seeker che può essere azionato entro
una zona operativa per l’ingaggio di bersagli singoli o multipli, a cui
s’aggiunge l’ottimizzazione dell’impiego in acquee costiere o alto-mare.
Attualmente installata sulle unità navali della MM della classe ‘Ammiragli’,
‘Doria’ e ‘Bergamini’, la versione Teseo Mk2/A si caratterizza per
canister dalle ridotte dimensioni per incrementare il numero di missili
imbarcabili (due al posto di uno) in una configurazione con interfaccia
per ogni lanciatore collegato al sistema di pianificazione della
missione, nonché sistema di combattimento e navigazione con dati forniti
dal GPS/INS e sistema data link per il controllo durante il volo.
In
aggiunta alla Marina Militare, la versione Teseo Mk/2A sarebbe stata
acquistata anche dal Turkmenistan per equipaggiare le unità da 55 metri
fornite dai cantieri turchi Dearsan, in una configurazione con un nuovo
lanciatore in materiale metallico, ridotte dimensioni e costi. Le
munizioni in servizio con la MM vengono sottoposte a periodiche attività
di mantenimento e revisione presso il CIMA con il supporto di MBDA, ma
come sopra evidenziato, la loro vita operativa si sta avvicinando alla
conclusione.

Per questo motivo la Forza
Armata e MBDA hanno avviato il piano di sviluppo sopra evidenziato, la
cui attività di definizione del progetto sulla base del requisito emesso
da NAVARM dovrebbe completarsi entro la fine dell’anno con
l’assegnazione del contratto per la fase di sviluppo e qualificazione
della nuova generazione del missile Teseo. In pratica, secondo quanto ha
appurato AD, Il Teseo Evo sarà un sistema d’arma polivalente con
capacità non soltanto antinave ma anche d’attacco su terra a media
distanza o light strike per distinguerlo da sistemi quali l’MCDN, il
Tomahawk o il Kalibr, che vengono definiti come armi da ‘deep strike’
per gittate nell’ordine o superiori al migliaio di chilometri.
Per
soddisfare tale requisito, la nuova versione Mk2/E si prevede che sia
dotata di un motore turbofan al posto dell’attuale turbogetto, il cui
modello peraltro già esistente dovrebbe essere fornito dall’americana
Williams, fornitrice di turbofan per i sistemi missilistici americani,
con serbatoio strutturale e nuovo sistema anti-G. Grazie a quest’ultimo
sistema propulsivo, il Teseo Evo dovrebbe avere una portata praticamente
doppia rispetto all’attuale sistema, che comporta inevitabilmente
modifiche alla cellula oltre che ai sistemi di controllo ed
all’elettronica di missione ed un nuova o migliorata testata in guerra.
Secondo quanto è stato possibile appurare nel corso del salone di
Seafuture 2018 da una presentazione effettuata da MBDA alla presenza di
delegazioni di Marine estere, in aggiunta al nuovo motore turbofan, la
nuova versione presenterebbe una cellula con efficienza aerodinamica
migliorata ed incremento non soltanto della manovrabilità ma anche della
sopravvivenza della munizione grazie si presume ad una ridotta segnatura
radar determinata anche da materiali ad hoc. Secondo alcune fonti,
l’immagine della nuova cellula con spaccato interno che è apparsa nel
corso della presentazione, sarebbe legata al completamento della fase
dello studio di fattibilità, ma MBDA avrebbe successivamente offerto e
starebbe valutando la possibilità di una cellula diversa, che si presume
similare ai missili da crociera, il che offrirebbe il vantaggio della
possibilità di lancio multipiattaforma, vista la capacità light strike
offerta dal sistema.

A questa s’aggiunge, mettendo
a fattore comune l’attività e le tecnologie in fase di adozione per il
Marte ER, una completa rivisitazione dell’elettronica e dei sistemi di
bordo, con un nuovo ricevitore GPS ed altimetro radar, nonché un seeker
di nuova generazione.
Per assicurare la doppia capacità antinave e light
strike, il Teseo Evo sarebbe equipaggiato con un seeker multi-banda
comprendente la radiofrequenza e secondo quanto riportato, almeno un
ricevitore laser semi-attivo. Per incrementare ulteriormente le capacità
del sistema d’arma, la nuova versione del Teseo dovrebbe avere una
testata in guerra scalabile potenziata.
A tal riguardo, nell’ambito del
piano nazionale della ricerca militare, MBDA ha portato a termine
attività di studio e sperimentazione dei materiali reattivi per
l’applicazione a sistemi d’arma di produzione propria quali il Marte ER,
Teseo Evo, CAMM ER (senza contare l’incremento di efficacia su
intercettore ATBM).
I materiali reattivi sono metalli o semi-metalli con
proprietà meccaniche adeguate alla realizzazione dell’involucro
strutturale della testa in guerra (TIG). Essi aumentano la letalità
delle TIG, abbinando un considerevole effetto esplosivo all’effetto
cinetico della proiezione di frammenti. L’intenzione è quella di
utilizzare i materiali reattivi per la realizzazione di TIG penetranti,
a frammentazione o multi-effetto.

Ulteriori fasi del programma
sono previste con potenziali sperimentazioni applicate a TIG per prove
reali.
Per assicurare una capacità di riprogrammazione in volo e
conseguentemente ottimizzare i tempi per l’ingaggio del bersaglio
prescelto, oltre ad una verifica della distruzione del medesimo (BDA,
Battle Damage Assessment), MBDA Italia sta portando avanti, nell’ambito
del Piano della Ricerca Militare Nazionale, sviluppi ulteriori del
programma Mercure che ha già visto la realizzazione di un data link a
‘due vie’ tramite satellite SICRAL e la sua potenziale applicazione al
sistema Teseo.
La nuova versione di quest’ultimo sarebbe inoltre dotata
di un nuovo canister più leggero per impiego a perdere (one-shot) e di
un sistema di pianificazione della missione migliorato in parallelo ad
un supporto ottimizzato per il ciclo vita dell’arma. In aggiunta ad
ampliare le capacità antinave e strike del sistema d’arma, lo sviluppo
del Teseo EVO consentirebbe di sviluppare e mantenere delle capacità in
diverse aree e tecnologie strategiche che costituirebbero un importante
bagaglio che la Difesa e l’Industria nazionale potrebbero portare sul
piatto della bilancia in vista della partecipazione al programma
anglo-francese FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon) per lo sviluppo
di un missile antinave e ‘deep-strike’ di nuova generazione destinato ad
entrare in servizio alla fine degli anni 2020.

Nell’ambito di quest’ultimo,
nel marzo 2017 è stato lanciata una fase triennale di valutazione
preliminare delle tecnologie e soluzioni tecniche che potrebbero essere
incorporate nella nuova famiglia di sistemi missilistici destinati a
rimpiazzare i missili antinave Harpoon, Exocet e aviolanciabili Storm
Shadow/Scalp EG.
Secondo quanto risulta ad AD, Segredifesa starebbe
valutando, fondi permettendo, di entrare quale osservatore nel programma
a partire dal prossimo anno, assicurandosi la possibilità di analizzare
e seguire lo sviluppo del medesimo per essere pronta alla sua
partecipazione con le giuste tecnologie e soluzioni tecniche.
Il CAMM ER Come sopra
riportato, lo stabilimento di La Spezia ed il sito di Aulla di MBDA
Italia non rappresentano soltanto il cluster d’eccellenza nel settore
dei sistemi antinave, ma registrano anche una lunga tradizione nel
settore dei sistemi missilistici superficie-aria con i sistemi navali
Albatros e munizione Aspide e SAAM-IT/SAAM ESD e relativi sviluppi con
la famiglia di missili Aster.

A questi a breve s’aggiungerà
il sistema missilistico EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions)
basato sulla munizione CAMM ER (Common Anti-Air Modular Missile Extended
Range) destinato all’Aeronautica Militare ed all’Esercito Italiano, ed
oggetto di valutazione da parte della Marina Militare.
Lanciato come
private-venture da MBDA Italia nel 2012, il programma EMADS/CAMM ER è
stato prescelto quale rimpiazzo, a partire dal 2021, delle linee di
munizioni Aspide facenti parte rispettivamente del sistema Spada
dell’AMI e del sistema Skyguard dell’EI.
Caratteristiche peculiari del CAMM ER sono il sistema di guida attiva dotato di seeker a
radiofrequenza per l’impiego ognitempo, ed sistema di lancio di tipo
“soft launch”, che permette l’accensione del booster ad una distanza dal
lanciatore sufficiente a salvaguardarne l’integrità.

La versione CAMM ER deriva
dal missile CAMM (di cui peraltro una significativa comunanza di
componenti) da cui se ne differenzia principalmente per una maggiore
lunghezza (4,2 contro 3,2 metri) e peso (160 contro 99 kg), conseguenze
dell’adozione di un nuovo e più potente sistema propulsivo, sviluppato e
prodotto dalla società Avio, che ne incrementa la portata ad oltre 40
km, a cui s’aggiunge una nuova configurazione aerodinamica con quattro
ali a basso allungamento che si estendono lungo la sezione
centro-posteriore del missile.
Tali caratteristiche assicurerebbero
prestazioni di manovrabilità similari se non superiori a sistemi più
prestanti dell’attuale generazione.

Il CAMM ER si caratterizza
per capacità ognitempo, ingaggio simultaneo contro bersagli multipli a
360° e nei confronti delle previste future minacce aeree, un data link a
due vie fra il missile ed il sistema di lancio che permettono di operare
senza la necessità di radar di controllo del tiro ed illuminatori, in
aggiunta alla capacità di essere designato da una fonte esterna.
Lanciato come private-venture, il programma di sviluppo del CAMM ER ha
visto una definizione contrattuale con finanziamento di 95 milioni di
euro spalmati su tre anni, i cui fondi sono già allocati dal precedente
Governo ed al tempo stesso è stata completata la negoziazione
contrattuale fra Segredifesa (TERRARM) e MBDA così come è già stato
definito l’Implementation Agreement che regola la governance tra il
Ministero della Difesa italiano e quello britannico.

Manca soltanto il definitivo
via libera del nuovo Parlamento e la firma del contratto a seguito del
quale sarà esecutivo anche all’accordo con l’MoD UK regolante il
workshare e la suddivisione delle quote di mercato export derivante dal
fatto che il CAMM ER è un’evoluzione del CAMM, diventando a tutti gli
effetti un programma binazionale.
Il programma prevede il completamento
dello sviluppo e qualifica del missile, lo sviluppo e qualifica del
sistema di lancio dotato di proprio sistema di up-link, nonché la sua
integrazione, in ambito nazionale, con i sistemi missilistici di
prossima dotazione delle due Forze Armate: Posto Comando Modulo di
Ingaggio (PCMI) Forza NEC per l’Esercito Italiano, dotato di radar di
scoperta Rheinmetall Italia X-TAR 3D in banda ‘X’ destinato a
rimpiazzare lo Skyguard Aspide per la protezione delle forze in teatro
dalle minacce a bassa quota Medium Advanced Air Defence System – MAADS
per l’Aeronautica Militare, destinato alla difesa di aeroporti e basi e
che impiegherà il Posto Comando SIRUS dotato di radar di scoperta
multifunzionale Leonardo KRONOS 3D LAND, già adottato per
l’aggiornamento di una parte delle attuali batterie Spada.

Il lanciatore comune ad
entrambi le soluzioni, è frutto del medesimo sviluppo del sistema di
lancio inglese Land Ceptor, caratterizzato da una configurazione di 8
missili per lanciatore. Nel caso italiano è previsto l’impiego
dell’autocarro Astra 88.45 BAD, mentre il comando e controllo della
batteria dovrebbe basarsi sullo shelter PC/radar sopra descritti.
Quest’ultima
dovrebbe gestire da 3 a 6 lanciatori. Il programma di sviluppo del CAMM
ER prevede il primo lancio della munizione ai primi del 2019, ed
introduce un’importante novità rappresentata dallo studio di fattibilità
dell’integrazione del sistema a bordo delle nuove unità della Marina
Militare ed in particolare dei Pattugliatori Polivalenti d’Altura e dei
futuri pattugliatori di squadra/fregate leggere (PPX). Mantenendo in
comune la munizione con le altre Forze Armate, per la versione
navalizzata del CAMM ER, che MBDA ha chiamato Albatros NG (New
Generation), quest’ultima sta lavorando a tre possibili soluzioni per il
sistema di lancio, sfruttando il VLS Sylver A50, il Lockheed Martin ExLS
ed infine una soluzione similare a quella utilizzata per il CAMM a bordo
delle fregate britanniche Type 23 in sostituzione del sistema Sea Wolf.

Quest’ultima soluzione
rappresenta la novità, con un sistema derivato da quello adottato per il
refit delle fregate Type 23 britanniche ed il rimpiazzo del sistema Sea
Wolf con il Sea Ceptor (CAMM). Tale soluzione prevede l’aggancio del
singolo canister del missile ad una piastra in un blocco da 2×3 canister,
distanziati e leggermente inclinati fra loro. Una soluzione dai bassi
costi che offrirebbe un’equilibrata difesa negli scenari maggiormente
variegati.
La proposta di Lockheed Martin e MBDA è basata su una
versione modificata (per munizione più lunga) del sistema di lancio
indipendente a 3 celle ExLS (Extensible Launching System), che ha
completato con successo la qualificazione con il sistema missilistico
CAMM all’inizio di aprile. Sfruttando l’esperienza sviluppata con il
sistema Mk 41, il nuovo lanciatore dai costi contenuti a 3 celle ExLS
viene proposto per le unità di minori dimensioni che non possono
accogliere il complesso di lancio MK 41 da 8 celle. Nel caso specifico,
ciascuna cella dell’ExLS è in grado di accogliere 4 CAMM e può essere
inserito in un lanciatore Mk 41 (ExLS Host), soluzione che è stata
testata con successo alla fine del 2017. Infine, la soluzione
rappresentata dai VLS DCNS Sylver A50, che grazie ad un’opportuna
compartimentazione interna a diagonale, potrebbe ospitare due CAMM ER.
Foto
MBDA |
 I
fondi erogati dalla Regione ammontano a
complessivi 45mila euro
I
fondi erogati dalla Regione ammontano a
complessivi 45mila euro
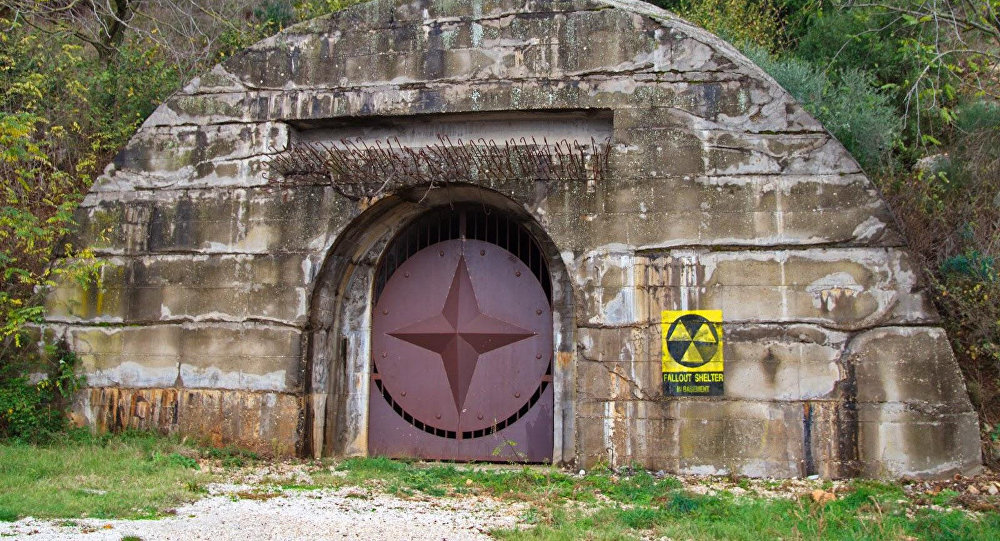






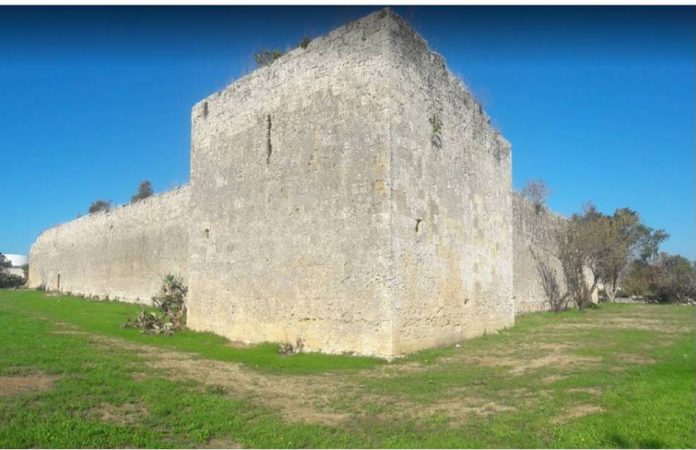


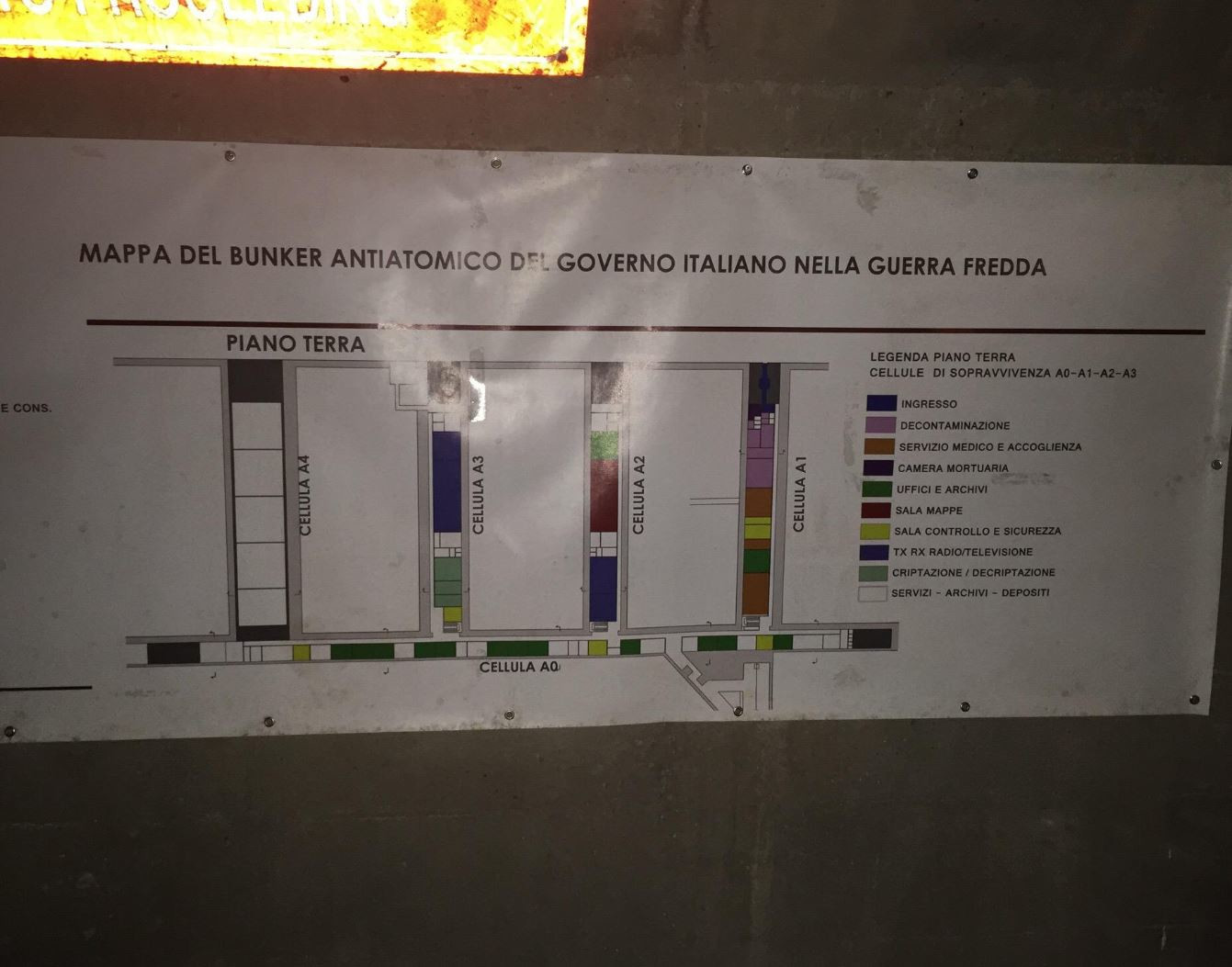






 LECCE
– Si terrà oggi pomeriggio, alle ore
16.30, l’inaugurazione del nuovo Parco
delle Mura Urbiche dopo i lavori di
recupero e valorizzazione che hanno
interessato il tratto nord occidentale e
l’area ex Carlo Pranzo. I cittadini
presenti, guidati dai tecnici
progettisti dell’intervento l’Architetto
Patrizia Erroi, il Dottor Gianluca
Tramutola, l’Architetto Andrea Ingrosso
e dal Professor Paul Arthur, potranno
passeggiare lungo i nuovi spazi
completamente recuperati. I lavori di
questo 2° lotto, avente un costo
complessivo di 4.172.000 euro a valere
sui fondi POIn/FESR e del PAC, sono
stati eseguiti dall’impresa Mello srl ed
hanno riguardato in particolare il
restauro di un ulteriore tratto di cinta
muraria, la sistemazione dell’area
antistante i Bastioni ed ex Carlo
Pranzo, il completamento dello
svuotamento del fossato e il recupero
del giardino storico di Palazzo Giaconia.
Nell’area ex Carlo Pranzo, in
corrispondenza della parte antistante il
ciglio esterno del fossato
cinquecentesco, gli scavi archeologici,
che sono stati eseguiti nell’ambito di
questo 2° lotto sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza e del
prof. Paul Arthur, hanno fatto emergere
una porzione significativa di strada
romana (che presumibilmente collegava
Lupiae a Brundisium) il cui tracciato è
stato interrotto in età medioevale dalla
costruzione di un sistema difensivo, del
quale sono ora visibili le fondazioni di
un tracciato murario e un antistante
fossato. A tali presenze monumentali si
sono aggiunti altri significativi
ritrovamenti, tra i quali i resti in
fondazione delle strutture murarie del
campo Polisportivo “Gino Buttazzi”
(1923) e del centro polisportivo
“Achille Starace” (1924). Come riportato
nella relazione del progetto, redatto
dall’Ufficio Centro Storico del Comune
di Lecce, si tratta di resti di
manufatti murari risalenti a epoche
diverse che ora, accostati l’uno
all’altro, formano un irripetibile ed
inedito palinsesto archeologico, che
testimonia “dal vero” la storia dello
sviluppo urbanistico di un pezzo
significativo della città. Un’area
urbana, fino a poco tempo addietro
adibita provvisoriamente a parcheggio,
sul cui fondale si ergeva la Cinta
muraria percepita come un relitto
trascurato e danneggiato dal tempo,
adesso, dopo l’intervento di restauro
conservativo e l’emergere dei
ritrovamenti archeologici , si è
trasformata in un accattivante paesaggio
di pietra, dotato di una intrinseca
qualità figurativa data
dall’intersecarsi – secondo diverse
direttrici, inclinazioni ed altimetrie –
di manufatti viari, circuiti difensivi
con fossati, canalizzazioni, etc. Un
paesaggio lapideo costituito da un unico
materiale (la pietra leccese ovvero la
biocalcarenite di età miocenica) diventa
elemento di memoria cittadina che
racconta al fruitore del nuovo percorso
di visita turistico-culturale cosa è
accaduto in oltre 2000 anni di storia
nell’area di sedime prossima al
tracciato della cinta muraria
cinquecentesca. Per l’area del giardino
storico di Palazzo Giaconia, che
rappresenta una stratificazione di usi
dal 1500 ad oggi, l’intervento ha mirato
a ricostituirne l’immagine complessiva,
preservando i caratteri propri dei
giardini murati cittadini, in termini di
componenti architettoniche,
vegetazionali e di arredo. All’interno
del giardino, dopo l’eliminazione delle
erbe infestanti e l’accantonamento nei
siti di ritrovamento degli elementi
lapidei superstiti, sono stati eseguite
– alla presenza di archeologi che hanno
documentato nel dettaglio i risultati
conseguiti – numerose trincee di scavo
che hanno consentito l’individuazione
delle quote originarie dei
terrazzamenti, la riscoperta delle
originarie scale in pietra leccese che
collegavano il giardino basso con il
giardino in quota, il riemergere dal
sottosuolo di singolari elementi di
arredo ed altri elementi architettonici
in pietra leccese che un tempo
corredavano il giardino (balaustra
modanata, pozzi, fontane, cordonature,
vasche, fioriere in pietra, ecc.).
LECCE
– Si terrà oggi pomeriggio, alle ore
16.30, l’inaugurazione del nuovo Parco
delle Mura Urbiche dopo i lavori di
recupero e valorizzazione che hanno
interessato il tratto nord occidentale e
l’area ex Carlo Pranzo. I cittadini
presenti, guidati dai tecnici
progettisti dell’intervento l’Architetto
Patrizia Erroi, il Dottor Gianluca
Tramutola, l’Architetto Andrea Ingrosso
e dal Professor Paul Arthur, potranno
passeggiare lungo i nuovi spazi
completamente recuperati. I lavori di
questo 2° lotto, avente un costo
complessivo di 4.172.000 euro a valere
sui fondi POIn/FESR e del PAC, sono
stati eseguiti dall’impresa Mello srl ed
hanno riguardato in particolare il
restauro di un ulteriore tratto di cinta
muraria, la sistemazione dell’area
antistante i Bastioni ed ex Carlo
Pranzo, il completamento dello
svuotamento del fossato e il recupero
del giardino storico di Palazzo Giaconia.
Nell’area ex Carlo Pranzo, in
corrispondenza della parte antistante il
ciglio esterno del fossato
cinquecentesco, gli scavi archeologici,
che sono stati eseguiti nell’ambito di
questo 2° lotto sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza e del
prof. Paul Arthur, hanno fatto emergere
una porzione significativa di strada
romana (che presumibilmente collegava
Lupiae a Brundisium) il cui tracciato è
stato interrotto in età medioevale dalla
costruzione di un sistema difensivo, del
quale sono ora visibili le fondazioni di
un tracciato murario e un antistante
fossato. A tali presenze monumentali si
sono aggiunti altri significativi
ritrovamenti, tra i quali i resti in
fondazione delle strutture murarie del
campo Polisportivo “Gino Buttazzi”
(1923) e del centro polisportivo
“Achille Starace” (1924). Come riportato
nella relazione del progetto, redatto
dall’Ufficio Centro Storico del Comune
di Lecce, si tratta di resti di
manufatti murari risalenti a epoche
diverse che ora, accostati l’uno
all’altro, formano un irripetibile ed
inedito palinsesto archeologico, che
testimonia “dal vero” la storia dello
sviluppo urbanistico di un pezzo
significativo della città. Un’area
urbana, fino a poco tempo addietro
adibita provvisoriamente a parcheggio,
sul cui fondale si ergeva la Cinta
muraria percepita come un relitto
trascurato e danneggiato dal tempo,
adesso, dopo l’intervento di restauro
conservativo e l’emergere dei
ritrovamenti archeologici , si è
trasformata in un accattivante paesaggio
di pietra, dotato di una intrinseca
qualità figurativa data
dall’intersecarsi – secondo diverse
direttrici, inclinazioni ed altimetrie –
di manufatti viari, circuiti difensivi
con fossati, canalizzazioni, etc. Un
paesaggio lapideo costituito da un unico
materiale (la pietra leccese ovvero la
biocalcarenite di età miocenica) diventa
elemento di memoria cittadina che
racconta al fruitore del nuovo percorso
di visita turistico-culturale cosa è
accaduto in oltre 2000 anni di storia
nell’area di sedime prossima al
tracciato della cinta muraria
cinquecentesca. Per l’area del giardino
storico di Palazzo Giaconia, che
rappresenta una stratificazione di usi
dal 1500 ad oggi, l’intervento ha mirato
a ricostituirne l’immagine complessiva,
preservando i caratteri propri dei
giardini murati cittadini, in termini di
componenti architettoniche,
vegetazionali e di arredo. All’interno
del giardino, dopo l’eliminazione delle
erbe infestanti e l’accantonamento nei
siti di ritrovamento degli elementi
lapidei superstiti, sono stati eseguite
– alla presenza di archeologi che hanno
documentato nel dettaglio i risultati
conseguiti – numerose trincee di scavo
che hanno consentito l’individuazione
delle quote originarie dei
terrazzamenti, la riscoperta delle
originarie scale in pietra leccese che
collegavano il giardino basso con il
giardino in quota, il riemergere dal
sottosuolo di singolari elementi di
arredo ed altri elementi architettonici
in pietra leccese che un tempo
corredavano il giardino (balaustra
modanata, pozzi, fontane, cordonature,
vasche, fioriere in pietra, ecc.).

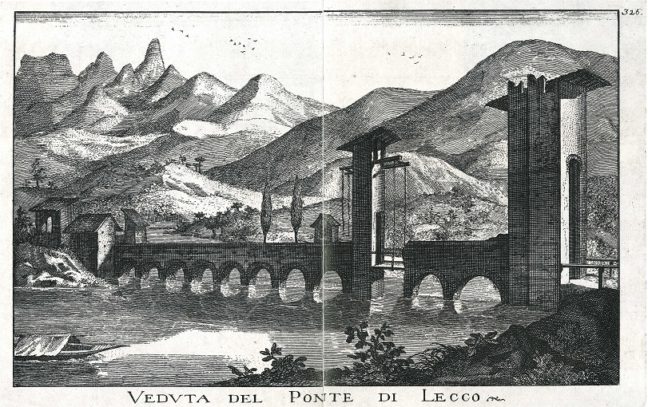
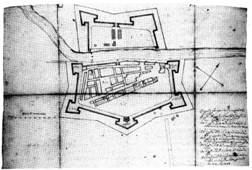





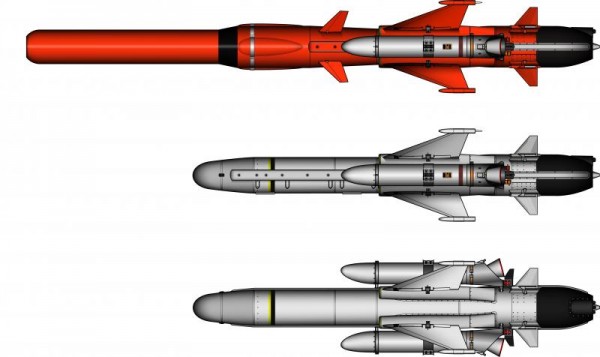
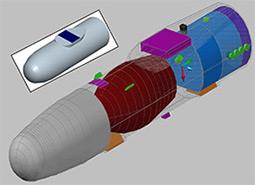 La
nuova arma, la Mk 2 venne sviluppata a
partire dal 1973 e il primo lancio venne
eseguito nel 1974. Lo sviluppo arrivò al
compimento nel 1976, in linea con
l'entrata in servizio del modello 1, ma
il primo lancio oltre l'orizzonte,
probabilmente dal poligono sardo di
Salto di Quirra, avvenne solo nel 1978.
Ben presto anche quest'arma arrivò in
servizio con la MM, ma inizialmente non
fu offerta all'export. Tecnicamente, il
missile si presentava come un'arma di
grosse dimensioni, non tanto per la
lunghezza, ma per la larghezza dovuta ad
una fusoliera larga 40 cm dotata di due
impulsori a razzo laterali ROXEL e un
turbogetto TR-281 ARBIZON III, 400 kg/s
che offre una spinta circa il 50%
maggiore che nel caso del similare
Harpoon. La testata, 210 kg è appena
davanti alla sezione motore che
comprende un totale di 90 litri,
sufficienti per almeno 10 minuti di
autonomia. La testa di ricerca è ancora
avanti e comprende un radar di ricerca
autonomo, ospitato dietro un muso in
materiale dielettrico. In definitiva, lo
schema della fusoliera, realizzata in
lega leggera di alluminio verte quindi,
da prua a poppa, nelle sezioni: guida,
elettronica, testata, carburante,
motore. Le superfici di controllo sono
quattro grosse ali stabilizzatrici al
centro fusoliera e quattro alette mobili
alla sua estremità posteriore.
La
nuova arma, la Mk 2 venne sviluppata a
partire dal 1973 e il primo lancio venne
eseguito nel 1974. Lo sviluppo arrivò al
compimento nel 1976, in linea con
l'entrata in servizio del modello 1, ma
il primo lancio oltre l'orizzonte,
probabilmente dal poligono sardo di
Salto di Quirra, avvenne solo nel 1978.
Ben presto anche quest'arma arrivò in
servizio con la MM, ma inizialmente non
fu offerta all'export. Tecnicamente, il
missile si presentava come un'arma di
grosse dimensioni, non tanto per la
lunghezza, ma per la larghezza dovuta ad
una fusoliera larga 40 cm dotata di due
impulsori a razzo laterali ROXEL e un
turbogetto TR-281 ARBIZON III, 400 kg/s
che offre una spinta circa il 50%
maggiore che nel caso del similare
Harpoon. La testata, 210 kg è appena
davanti alla sezione motore che
comprende un totale di 90 litri,
sufficienti per almeno 10 minuti di
autonomia. La testa di ricerca è ancora
avanti e comprende un radar di ricerca
autonomo, ospitato dietro un muso in
materiale dielettrico. In definitiva, lo
schema della fusoliera, realizzata in
lega leggera di alluminio verte quindi,
da prua a poppa, nelle sezioni: guida,
elettronica, testata, carburante,
motore. Le superfici di controllo sono
quattro grosse ali stabilizzatrici al
centro fusoliera e quattro alette mobili
alla sua estremità posteriore.
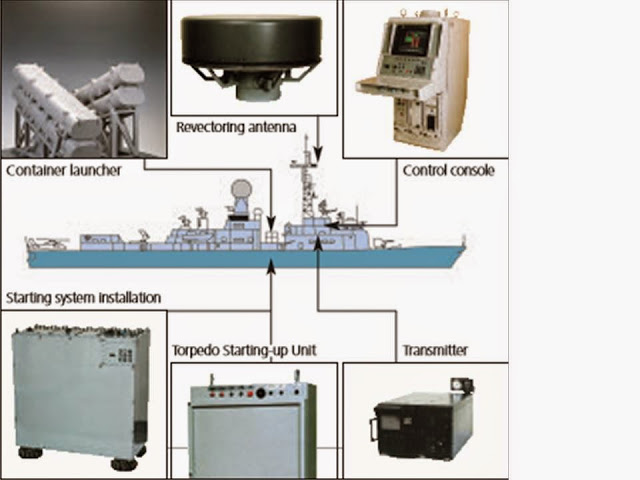
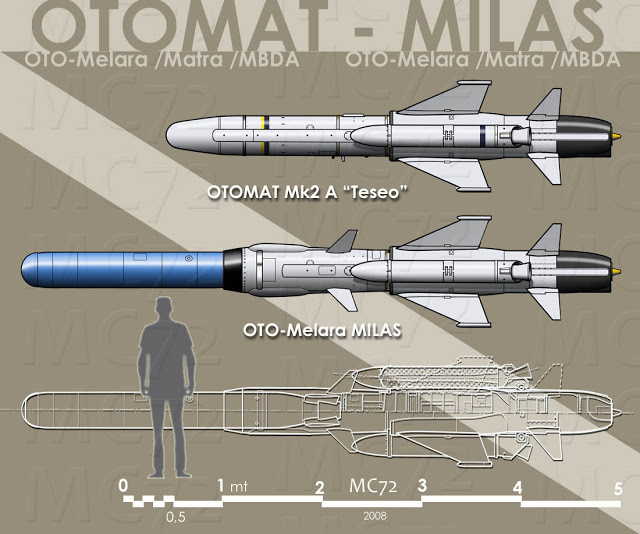
 Il
missile MILAS, del tipo antisom è stato
ideato e realizzato per sopperire
principalmente ai ritardi di intervento
degli elicotteri ASW cooperanti sulla
scena d'azione, che esercitano il ruolo
offensivo nei confronti del
sommergibile. Analogamente all'ASROC,anche
il MILAS, è costituito dalle seguenti
parti componenti:
Il
missile MILAS, del tipo antisom è stato
ideato e realizzato per sopperire
principalmente ai ritardi di intervento
degli elicotteri ASW cooperanti sulla
scena d'azione, che esercitano il ruolo
offensivo nei confronti del
sommergibile. Analogamente all'ASROC,anche
il MILAS, è costituito dalle seguenti
parti componenti: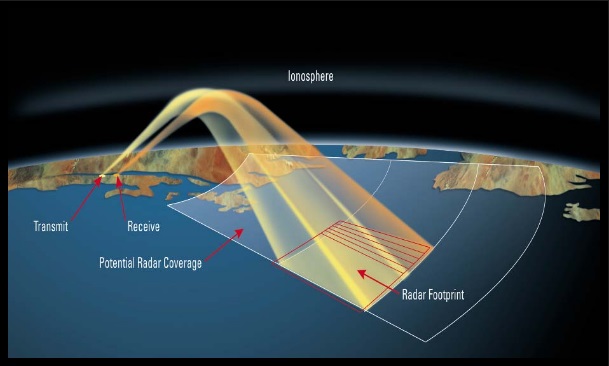 “Container”,
detto anche sistema 29B6, é il nuovo
radar russo OTH (Over the Horizon) la
cui prima stazione é stata impiantata
due settimane fa nella regione della
Mordovia.
“Container”,
detto anche sistema 29B6, é il nuovo
radar russo OTH (Over the Horizon) la
cui prima stazione é stata impiantata
due settimane fa nella regione della
Mordovia.









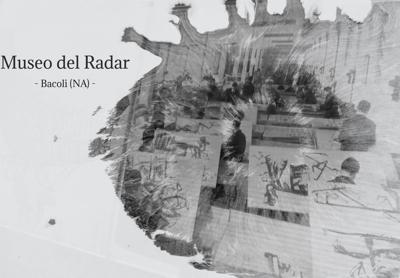


 La
sua struttura, molto caratteristica, era
aguzza e possente al tempo stesso, con
un insieme di caratteristiche che lo
rendevano unico tra i pur numerosi
missili antiaerei dell'epoca. Esso era
bistadio: il primo aveva ben 4 motori a
razzo con propellenti solidi, riuniti in
un complesso chiamato M42, studiato per
ridurre la lunghezza del missile a
valori accettabili, e realizzato con i
motori di accelerazione (booster) M5E1.
Esso era dotato anche di 4 ali
cruciformi per la stabilizzazione.
Questo complesso pesava da solo 2345 kg
e dava quasi 80.000 kg di spinta per 3,4
secondi.
La
sua struttura, molto caratteristica, era
aguzza e possente al tempo stesso, con
un insieme di caratteristiche che lo
rendevano unico tra i pur numerosi
missili antiaerei dell'epoca. Esso era
bistadio: il primo aveva ben 4 motori a
razzo con propellenti solidi, riuniti in
un complesso chiamato M42, studiato per
ridurre la lunghezza del missile a
valori accettabili, e realizzato con i
motori di accelerazione (booster) M5E1.
Esso era dotato anche di 4 ali
cruciformi per la stabilizzazione.
Questo complesso pesava da solo 2345 kg
e dava quasi 80.000 kg di spinta per 3,4
secondi.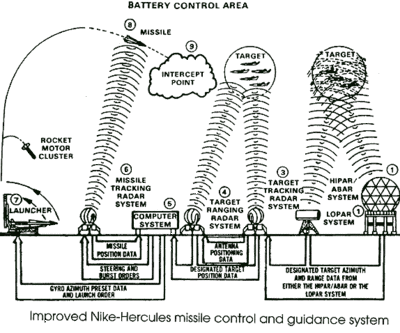 Gli
apparati a terra vennero presto
migliorati rispetto a quelli dell'
Gli
apparati a terra vennero presto
migliorati rispetto a quelli dell'

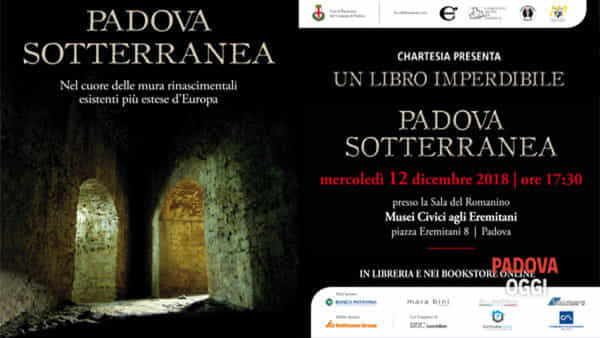











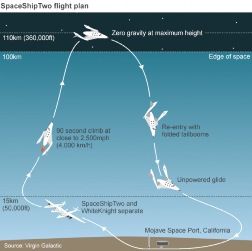


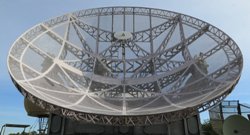
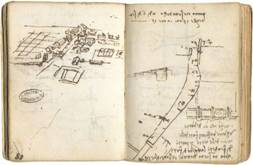


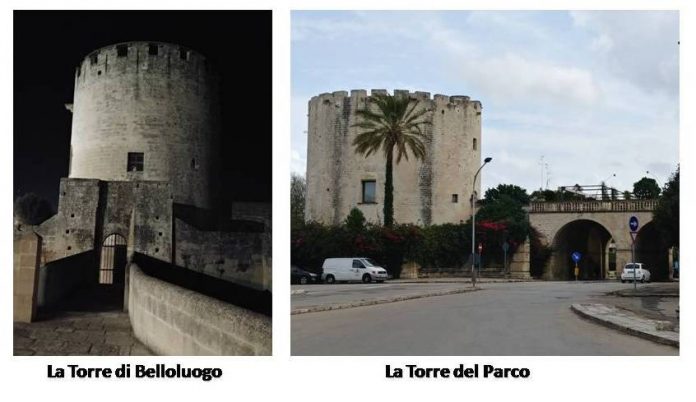








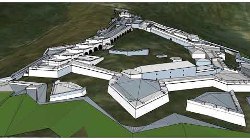




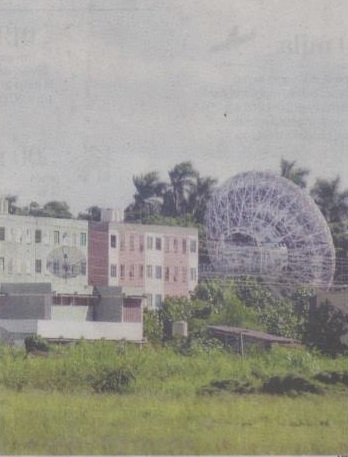



































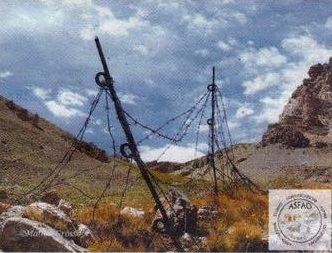






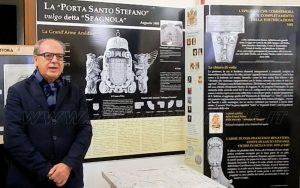














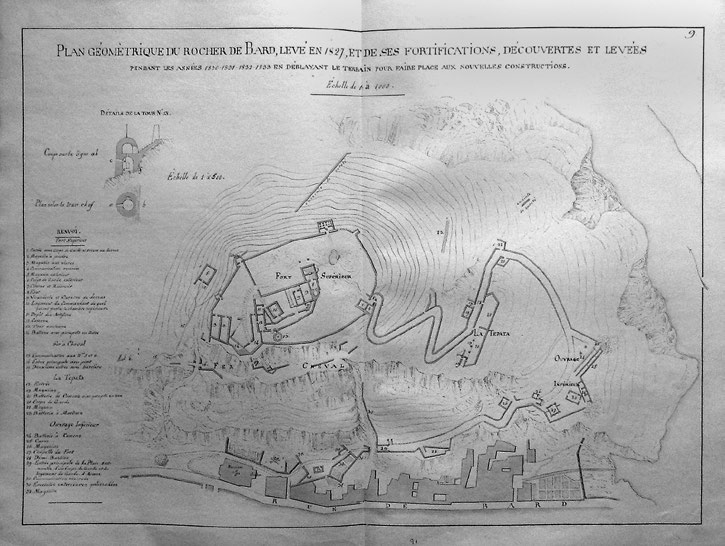
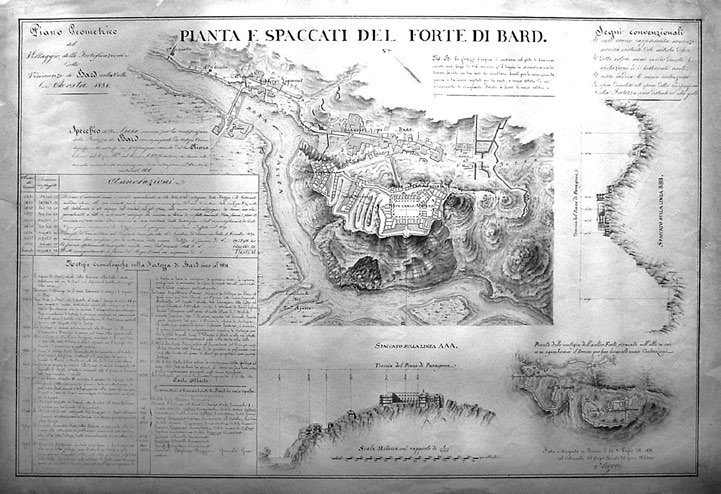
























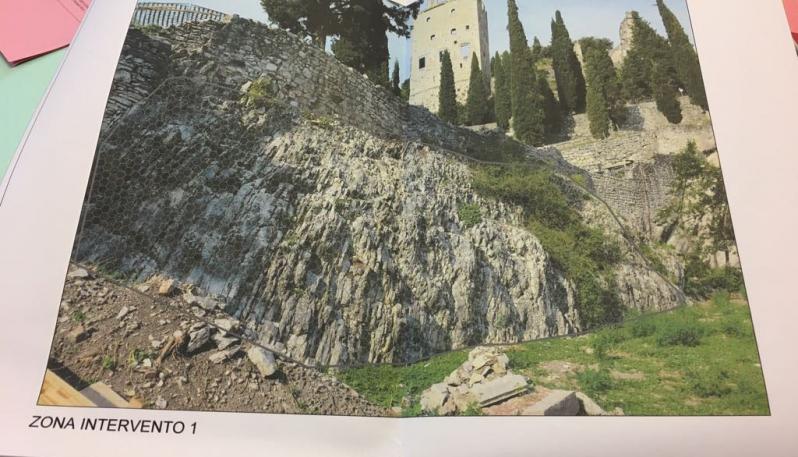



















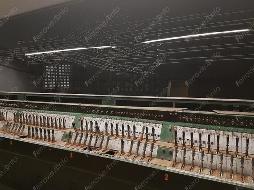

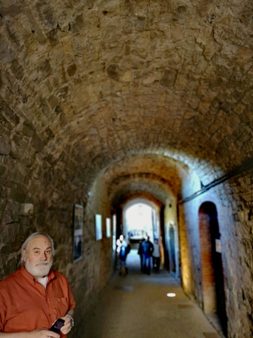
















.jpg)










 La
galleria anti-aerea venuta alla luce durante lavori di manutenzione al
manto stradale. «Dovrà essere svuotata, bonificata e resa sicura»
La
galleria anti-aerea venuta alla luce durante lavori di manutenzione al
manto stradale. «Dovrà essere svuotata, bonificata e resa sicura»












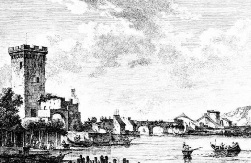



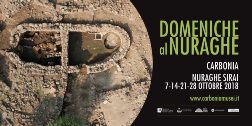













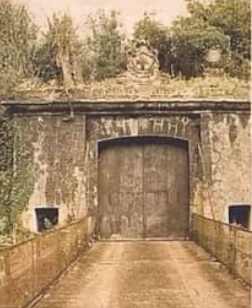


 Un
nuovo intervento di recupero e salvaguardia della cinta muraria di
Montecarlo grazie ad un contributo di 150 mila euro da parte del
Ministero dei Beni Culturali che sarà gestito direttamente dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Lucca e Massa Carrara di Lucca. Al recepimento del finanziamento,
contenuto nel piano di investimenti del Ministero che fa capo al Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito
dalla legge di bilancio 2017, ha direttamente operato l'amministrazione
comunale che lo scorso 18 gennaio ha tenuto un incontro presso la sede
del MiBAC a Roma alla presenza dei funzionari del ministero, del Sindaco
di Montecarlo Vittorio Fantozzi, del vicesindaco Luca Galligani e
dell'architetto Paolo Anzilotti. Durante l'incontro, richiesto da tempo
dal Comune di Montecarlo, gli amministratori hanno presentato ed
illustrato, oltre ai progetti di intervento urgente sulle mura, il
Master Plan per il recupero e la valorizzazione della cinta muraria
allegato al nuovo Piano Strutturale approvato nel novembre 2017.
Un
nuovo intervento di recupero e salvaguardia della cinta muraria di
Montecarlo grazie ad un contributo di 150 mila euro da parte del
Ministero dei Beni Culturali che sarà gestito direttamente dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Lucca e Massa Carrara di Lucca. Al recepimento del finanziamento,
contenuto nel piano di investimenti del Ministero che fa capo al Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito
dalla legge di bilancio 2017, ha direttamente operato l'amministrazione
comunale che lo scorso 18 gennaio ha tenuto un incontro presso la sede
del MiBAC a Roma alla presenza dei funzionari del ministero, del Sindaco
di Montecarlo Vittorio Fantozzi, del vicesindaco Luca Galligani e
dell'architetto Paolo Anzilotti. Durante l'incontro, richiesto da tempo
dal Comune di Montecarlo, gli amministratori hanno presentato ed
illustrato, oltre ai progetti di intervento urgente sulle mura, il
Master Plan per il recupero e la valorizzazione della cinta muraria
allegato al nuovo Piano Strutturale approvato nel novembre 2017.


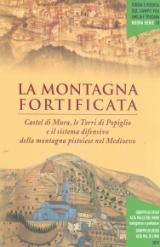 Da
martedì 25 settembre riprende il tradizionale ciclo di incontri
“Leggere, raccontare, incontrarsi…”. Iniziato nel 2008, il ciclo ogni
anno si propone in due edizioni, una primaverile e una autunnale, e con
lo scopo di promuovere la conoscenza di autori e storie locali. Gli
appuntamenti, organizzati dalla Biblioteca Forteguerriana e dalla
Biblioteca San Giorgio, si svolgono nelle stesse biblioteche e prevedono
prevalentemente la presentazione di libri, sia che si tratti di opere
che parlano di Pistoia e del suo territorio, sia che si tratti di opere
di autori pistoiesi che non necessariamente hanno Pistoia come
argomento.
Da
martedì 25 settembre riprende il tradizionale ciclo di incontri
“Leggere, raccontare, incontrarsi…”. Iniziato nel 2008, il ciclo ogni
anno si propone in due edizioni, una primaverile e una autunnale, e con
lo scopo di promuovere la conoscenza di autori e storie locali. Gli
appuntamenti, organizzati dalla Biblioteca Forteguerriana e dalla
Biblioteca San Giorgio, si svolgono nelle stesse biblioteche e prevedono
prevalentemente la presentazione di libri, sia che si tratti di opere
che parlano di Pistoia e del suo territorio, sia che si tratti di opere
di autori pistoiesi che non necessariamente hanno Pistoia come
argomento.
























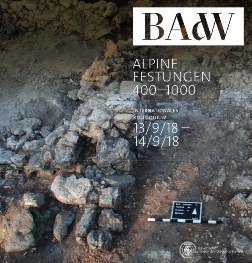
























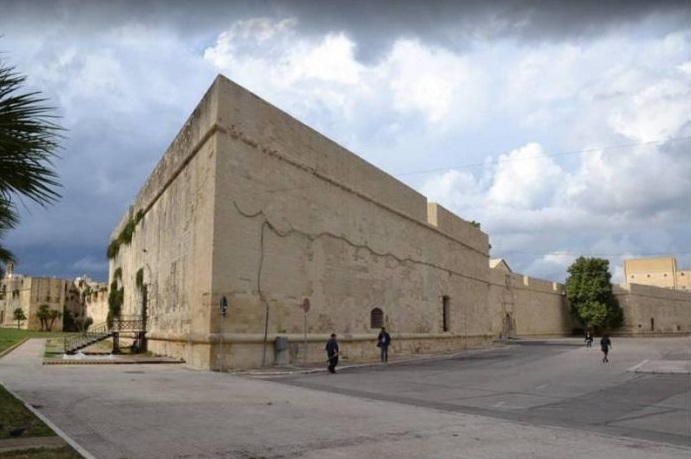


















 Controllava
le telecomunicazioni nell’area
mediterranea
Controllava
le telecomunicazioni nell’area
mediterranea 







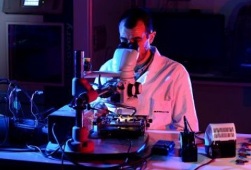


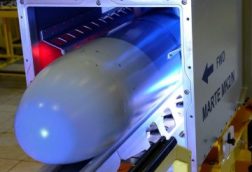

























































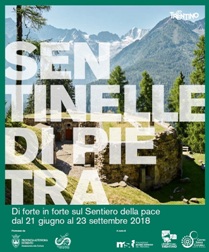
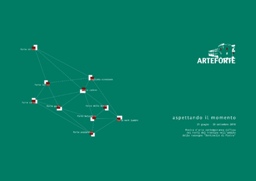















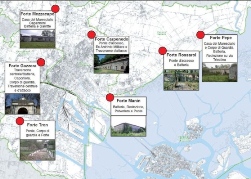


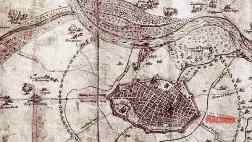



















 ALESSANDRIA -
ALESSANDRIA -